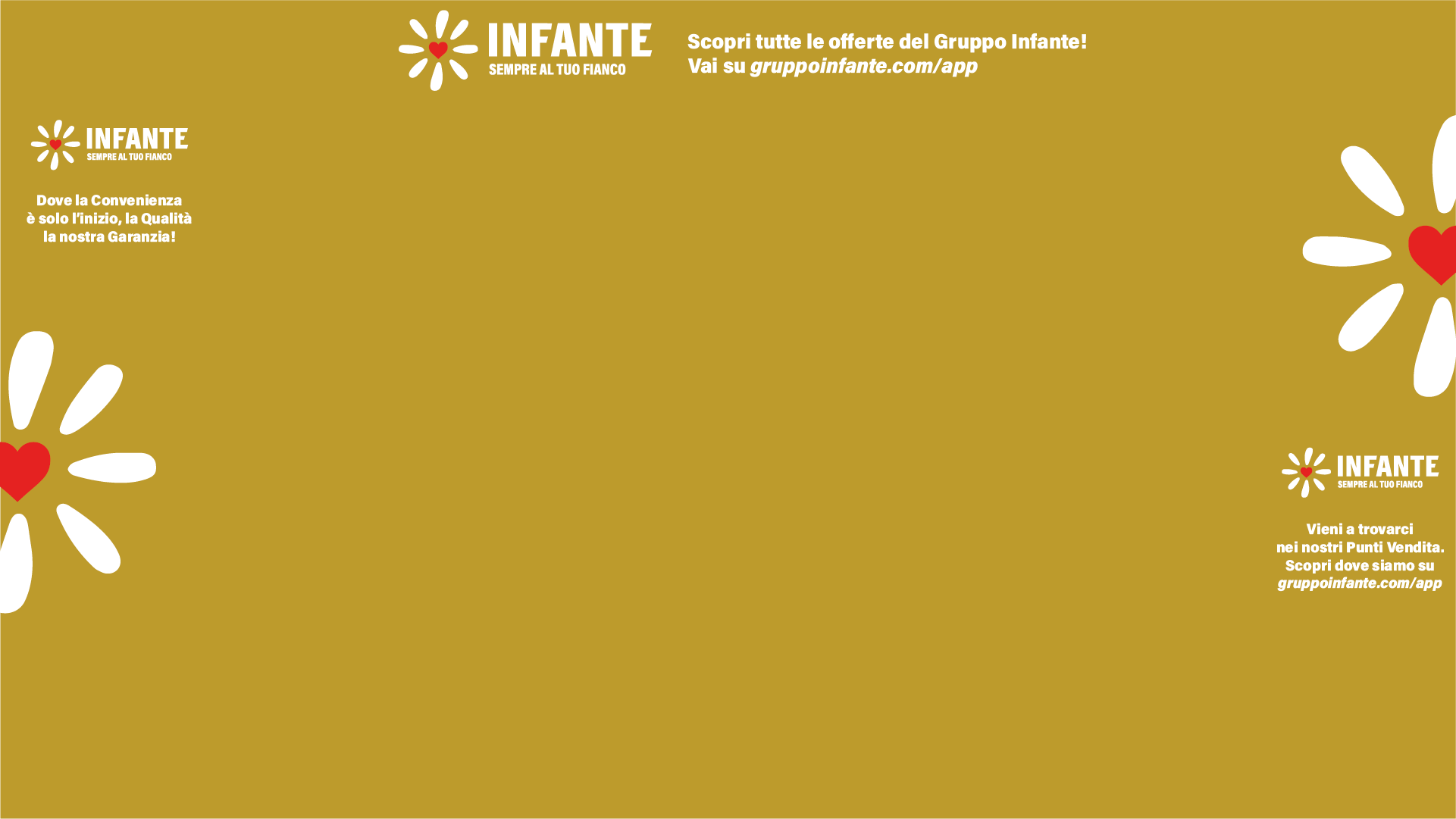Invocata per la protezione dalle malattie contagiose, dalle infermità degli occhi, della gola, del seno e soprattutto contro le violenze domestiche, Santa Rosalia è venerata come santa vergine in numerose comunità, in particolare nell’Italia Meridionale e soprattutto in Sicilia, sua terra d’origine.
Nata intorno al 1130 in una famiglia nobile, i Sinibaldi, Rosalia era figlia del conte Sinibaldo, signore della Quisquinia e del Monte delle Rose, territori oggi in provincia di Agrigento. La sua famiglia vantava una discendenza da Carlo Magno e dai Conti dei Marsi, mentre sua madre era legata alla corte normanna, forse cugina del re Ruggero II.
Una nascita annunciata
Secondo la tradizione, nel 1128 Ruggero II d’Altavilla, fondatore del Regno di Sicilia, avrebbe avuto una visione durante un tramonto osservato dal Palazzo Reale con la moglie Elvira. Una figura gli avrebbe annunciato la nascita di “una rosa senza spine” nella casa del suo congiunto Sinibaldo. Qualche anno dopo, nacque Rosalia, il cui nome unisce “rosa” e “lilium”, simboli di purezza.
Educata a corte, Rosalia si distinse per bellezza e grazia, tanto da diventare nel 1149 damigella d’onore della regina Sibilla. Il suo fascino attirò l’attenzione di molti nobili, tra cui il principe Baldovino, futuro re di Gerusalemme.
La scelta spirituale
Un episodio decisivo cambiò il corso della sua vita: alla vigilia delle nozze con Baldovino, Rosalia ebbe una visione di Cristo crocifisso. Interpretando l’apparizione come una chiamata alla vita consacrata, si presentò a corte con le trecce tagliate, rinunciando al matrimonio e alla vita mondana.
In un periodo di fervore religioso promosso dai Normanni, Rosalia si ritirò nel monastero delle basiliane del SS. Salvatore a Palermo. Tuttavia, le continue visite dei genitori e del promesso sposo la spinsero a cercare un luogo più isolato. Lasciò una lettera in greco e una croce di legno alle monache e si rifugiò in una grotta nei Monti Sicani, dove visse per dodici anni in preghiera e solitudine. Sulle pareti incise: «Io Rosalia, figlia di Sinibaldo, signore della Quisquinia e delle Rose, per amore del Signore mio Gesù Cristo, stabilii di abitare in questa grotta».
L’eremitaggio e la morte
Il suo rifugio divenne meta di pellegrinaggi, spingendola a cercare un luogo ancora più remoto: una grotta sul Monte Pellegrino. Qui, secondo la tradizione, morì il 4 settembre 1165, stremata dalla penitenza. Il suo nome compare già alla fine del XII secolo in documenti pontifici.
Il culto e la rinascita della devozione
Santa Rosalia fu presto oggetto di grande venerazione, con chiese dedicate in Sicilia e anche fuori regione, come a Rivello (Potenza). Tuttavia, all’inizio del Seicento, il culto era in declino.
Nel 1624, la palermitana Girolama Gatto, gravemente malata, ebbe una visione di una giovane vestita di bianco che le promise la guarigione se fosse salita sul Monte Pellegrino. Dopo aver bevuto l’acqua della grotta, si sentì guarita. In sogno, la giovane le indicò il luogo dove si trovava il suo corpo. Il 15 luglio, alcuni frati francescani trovarono delle ossa sotto un masso, poi trasferite nella cappella dell’arcivescovo di Palermo.
Nel frattempo, la città fu colpita dalla peste. Il cardinale convocò il popolo in cattedrale, invocando l’intercessione della Vergine Maria e proclamando Santa Rosalia patrona principale di Palermo. Nel giugno 1625, le reliquie furono portate in processione: dove passavano, i malati guarivano.
Le celebrazioni
Il 15 luglio 1625 si tenne il primo pellegrinaggio sul Monte Pellegrino. Da allora, la festa di Santa Rosalia si celebra in due date: il 15 luglio (U Fistinu), anniversario del ritrovamento delle reliquie, e il 4 settembre, giorno della sua morte.
Iconografia e simboli
Nell’arte popolare, Santa Rosalia è raffigurata come giovane e bella, con una corona di gigli e rose, vestita da eremita o con abiti regali. Tra i simboli ricorrenti: il teschio (fragilità umana), il libro (Vangelo o preghiere), la croce di legno, il bastone da pellegrino con giglio, la conchiglia (simbolo del pellegrinaggio) e una ciotola, ritrovata accanto alle sue ossa.
La devozione nel Cilento
Il 4 settembre è una data importante per diverse comunità cilentane, tra cui San Mango Cilento e Lentiscosa. In quest’ultima, la processione si svolge con i fedeli a piedi nudi e petali di rose lanciati dai balconi.
La festa suscita profonda commozione e partecipazione. Durante la novena, si canta: «Dei morbi contagiosi / Iddio ti fe’ regina / Perciò di tal rovina / Salvaci per pietà».
Parole che risuonano con particolare intensità nel contesto della pandemia da Covid-19, quando i fedeli hanno rivolto alla Santa ferventi preghiere per la fine dell’emergenza sanitaria.