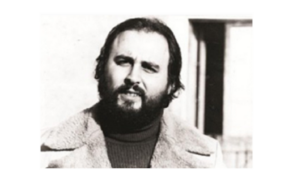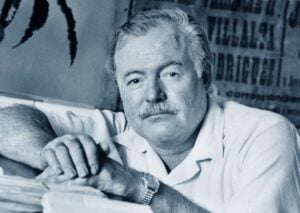Molto spesso usiamo nella nostra quotidianità di cilentani il termine “dialetto” e non di rado in maniera impropria. Resistono ancora, infatti, diversi pregiudizi legati a questa parola, ad esempio il fatto che il dialetto sia una varietà corrotta dell’italiano. Falso! Ogni dialetto è un sistema linguistico autonomo, mentre gli italiani regionali (parola più complessa che risale ad una definizione di Giovan Battista Pellegrino nel 1960) sono varietà diatopiche dell’italiano, nate in seguito all’unificazione nazionale nell’Ottocento.
La parola “dialetto” è coniata, come ci ricorda Serianni, nel Cinquecento, in riferimento non alla situazione linguistica italiana, ma a quella dell’antica Grecia. Tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento si prende coscienza della differenza fra italiano e dialetto. Quest’ultimo diventa codice linguistico di molte opere teatrali, come quelle di Carlo Goldoni, nelle quali si afferma ciò che Benedetto Croce ha chiamato “uso riflesso”, cioè non spontaneo e, anzi, deformato per ragioni stilistiche. Al contempo, a cavallo fra Seicento e Settecento, l’italiano comincia a diffondersi negli usi scritti, non soltanto letterari a seguito della codificazione normativa di Bembo con le “Prose della volgar lingua” (1525), ma anche in ambito giuridico, amministrativo e scientifico. Inoltre, mediante i quotidiani come “Il Caffè”, pubblicato a Milano fra il 1764 e 1766, l’italiano è soggetto per la prima volta ad lenta diffusione mediatica.
Nell’Ottocento, poi, dopo la nascita del Regno d’Italia, si afferma il problema dell’unificazione linguistica su due fronti: da un lato il dibattito su quale varietà debba essere assunta come standard, ovvero come lingua veicolare non solo letteraria, ma anche e soprattutto nei domini dell’oralità; dall’altro si discutono i mezzi e le strategie efficaci volte ad assicurare la diffusione dell’italofonia. Nel primo caso, si afferma la posizione manzoniana, per cui il fiorentino contemporaneo parlato dalle persone colte viene assunto come punto di riferimento (il registro linguistico finale de “I Promessi Sposi”). Riguardo ai mezzi per diffondere questa lingua, Manzoni stesso realizza mel 1868, per conto del Ministro dell’istruzione Emilio Broglio, una relazione nella quale definisce i punti principali da seguire per l’unificazione, fra cui l’invio di maestri toscani o la formazione in Toscana, a Firenze, dei futuri insegnanti. La scuola assume, quindi, un ruolo fondamentale.
A livello didattico si impone un clima dialettofobo (non era affatto favorevole Manzoni, il quale auspicava al contrario un “fondo comune” fra italiano e dialetto), responsabile dei tanti pregiudizi che ancora oggi stentano a scomparire, ad esempio l’idea del dialetto come una cattiva abitudine da correggere. In senso tecnico si afferma in quegli anni quello che i linguisti chiamano “bilinguismo sottrattivo”, ovvero il deterioramento della competenza in una lingua a vantaggio di un’altra per ragioni di spendibilità sociale e per la sua svalorizzazione tanto nella comunità sociale quanto a scuola. Un processo analogo ai giorni nostri sta avvenendo a scuola nel rapporto fra italiano e lingue d’origine degli alunni immigrati, cui si stanno opponendo diversi programmi didattici basati sulla valorizzazione del plurilinguismo.
Le differenze fra italiano e dialetto sono di ordine sociolinguistico, cioè l’italiano è la nostra lingua standard, quella che ci serve per muoverci quotidianamente nel nostro piccolo mondo nazionale. Il dialetto è, invece, la lingua dei nostri affetti, delle nostre emozioni, caratterizzato spesso da un forte valore identitario.
Weinreich afferma che la lingua è un dialetto con un esercito e una marina, mentre un dialetto è una lingua dotata di un piccolo esercito.
Questa estrema affermazione, che solo in parte riflette la storia linguistica dell’italiano, ci fa comprendere che le differenze fra dialetto e italiano sono di ordine socioculturale, legate al fatto che un dialetto non ha compiuto le fasi di un processo di standardizzazione a livello storico.
Dobbiamo, quindi, capire che ogni sistema linguistico è come un armadio nel quale abbiamo un vestito per ogni occasione. Non dobbiamo abbandonare il dialetto a discapito dell’italiano, ma semplicemente usarlo consapevolmente accanto all’italiano (oggi Berruto chiama questa situazione legata all’oralità “dilalìa”). Allo stesso modo, per favorire l’integrazione dei tanti immigrati nel nostro Stato, dobbiamo favorire l’incontro fra la loro lingua (che molto spesso è proprio un dialetto) e la nostra lingua, sia a scuola sia nei luoghi dove si svolgono le relazioni sociali. Inoltre, spesso si fanno connotazioni legate al genere: una donna che parla in dialetto è considerata ancora oggi volgare. Bisogna evitare anche questo pregiudizio assolutamente insulso. Non mancano, poi, usi incauti dei termini lingua e dialetto in coordinazione sintagmatica: quest’ultimi non dovrebbero a rigore sociolinguistico essere usati insieme in alcuni contesti testuali, cioè non posso dire di aver scritto una poesia in “lingua e dialetto napoletano”, come succede in certi concorsi letterari, in quanto l’uno e l’altro non sono su un piano di identità.
Infine, per celebrare questa giornata intendo riportare un canto amoroso che ho registrato anni fa e ho pubblicato ne “I cundi re na vota” (L’argolibro editore):
O fàcci re ‘na lattuga tenerèlla,
rosélla nu ccàngi mai colóre,
nu mme nge vulìvi nasce accussì bbèlla,
ca nu ddìvi tanda pèna a mmàmma tóa.
Tu parti e tte nne vai contènta,
la mamma tóa la lasci cco ddolóre.
Chésta è la carta ca camìna sèmbe
che ogni figlia ‘na mamma abbandóna.